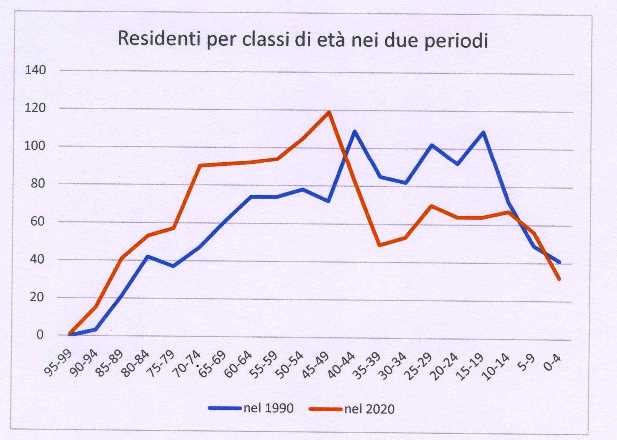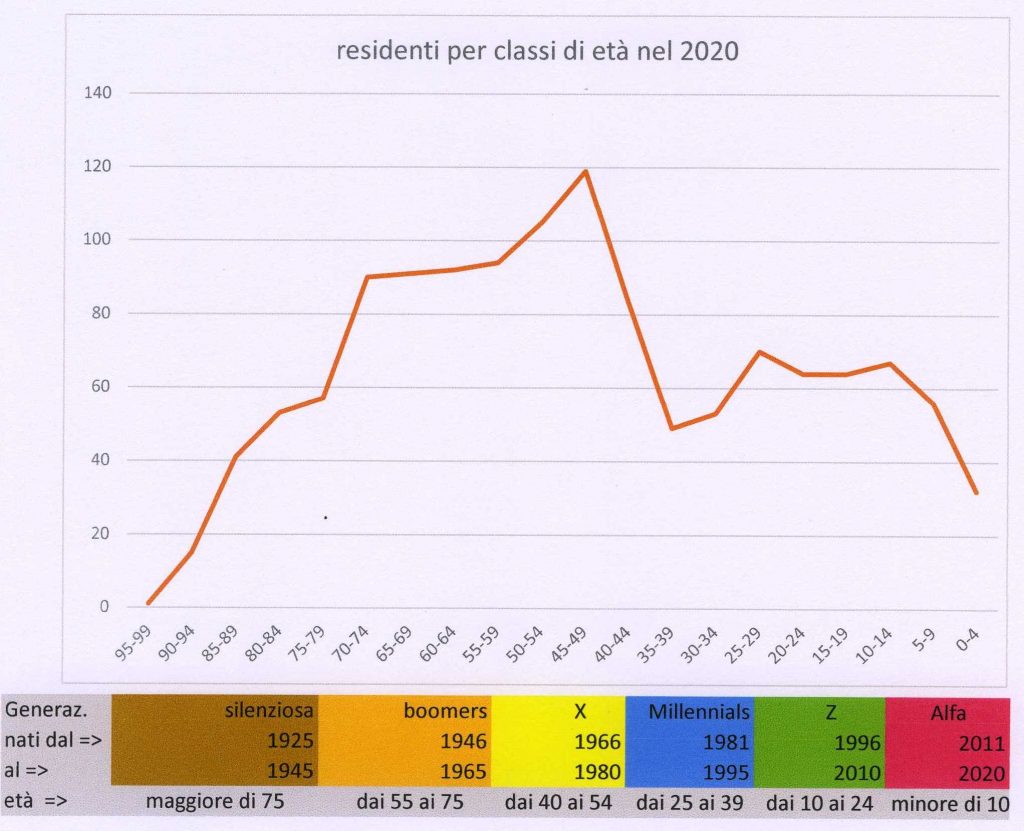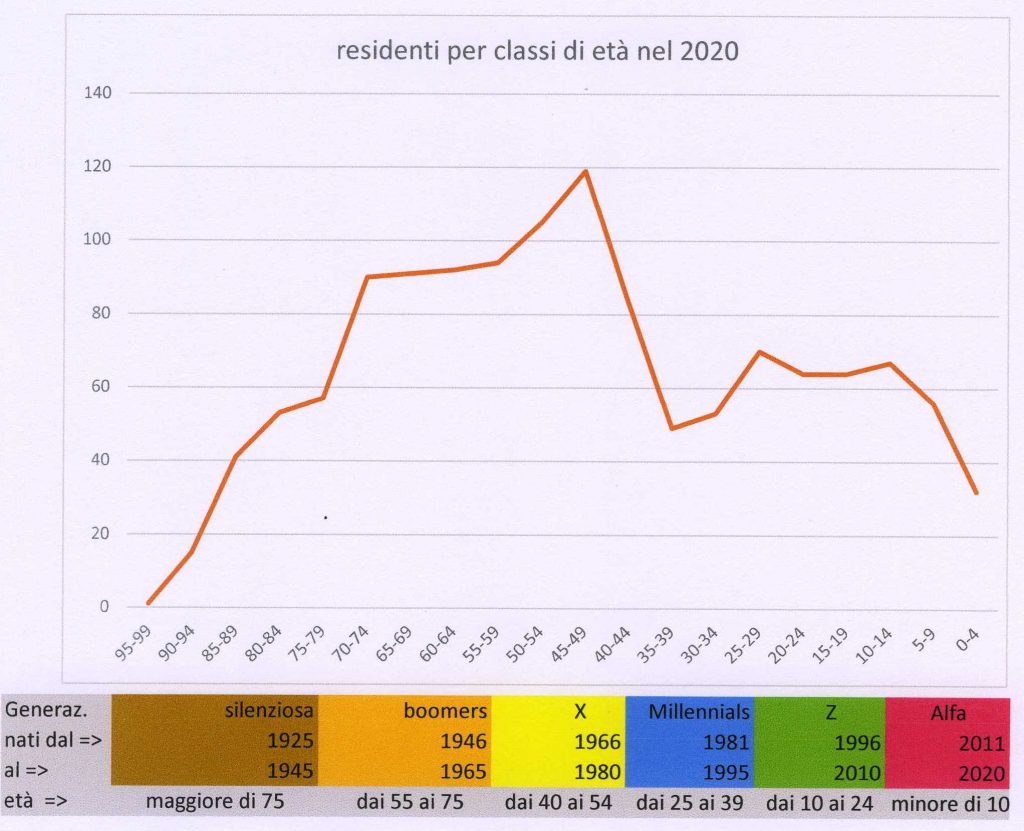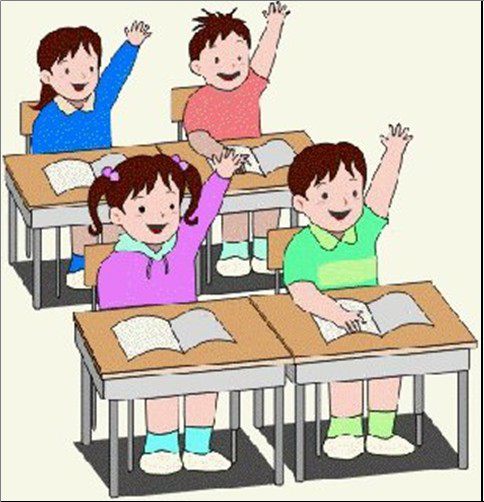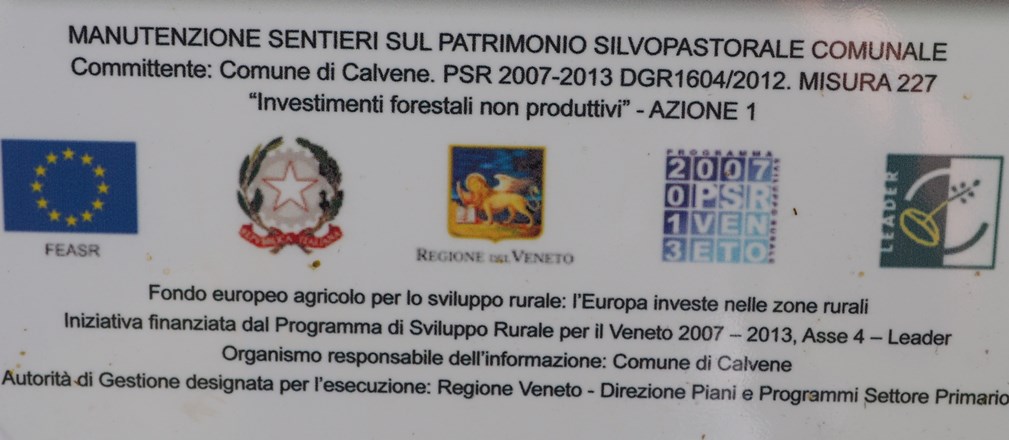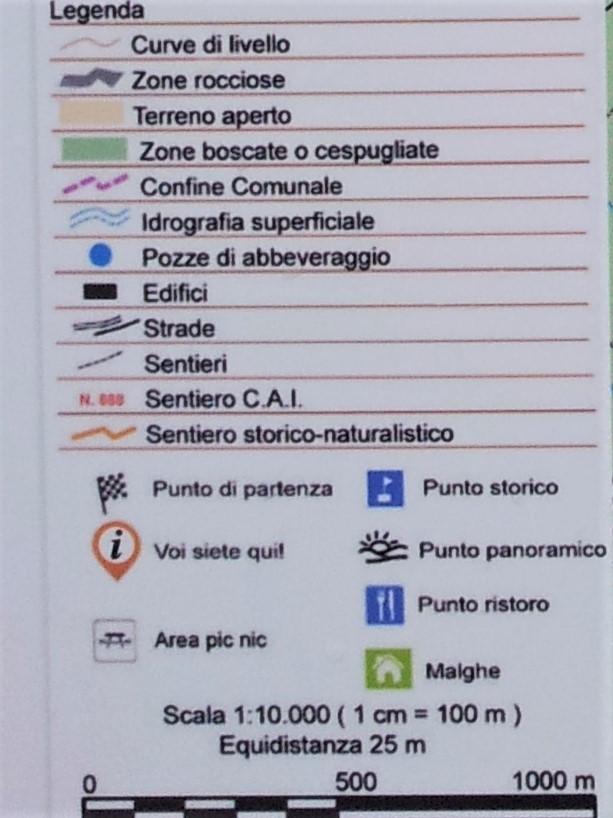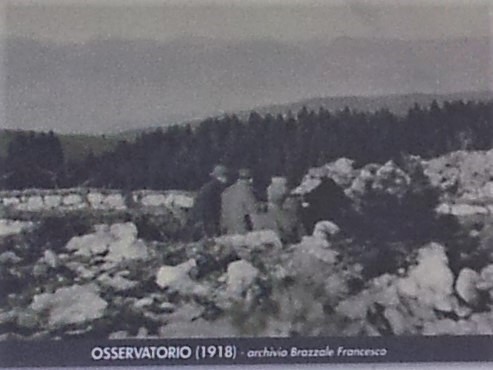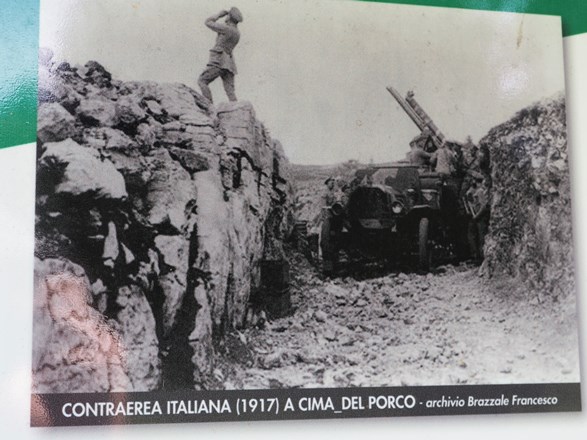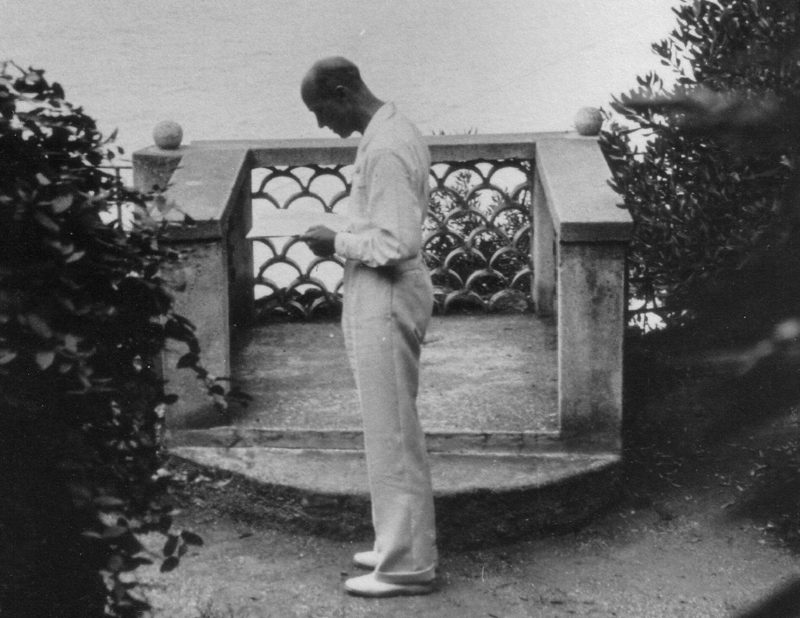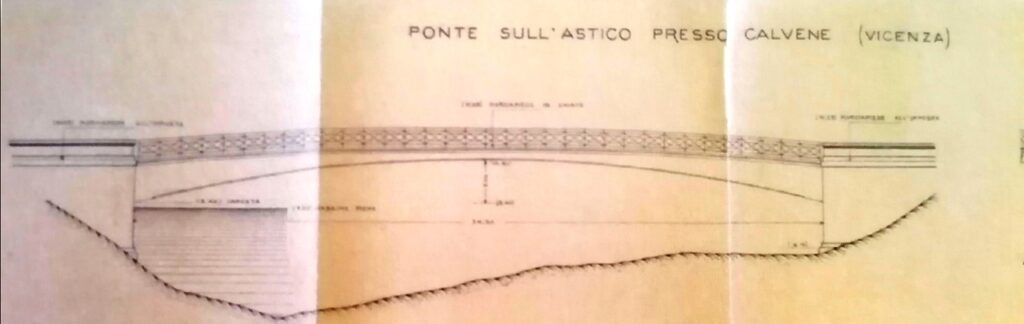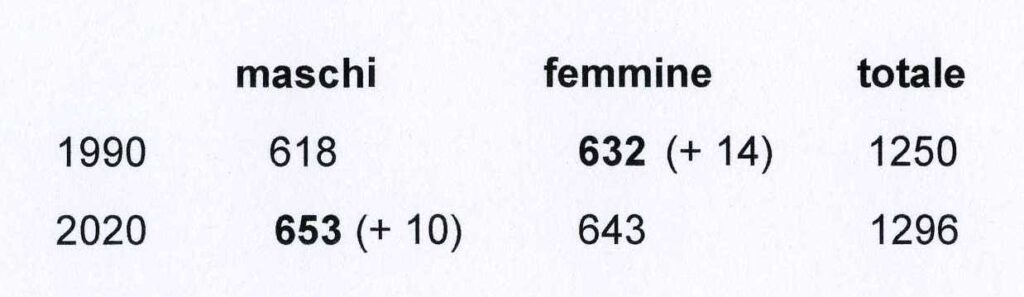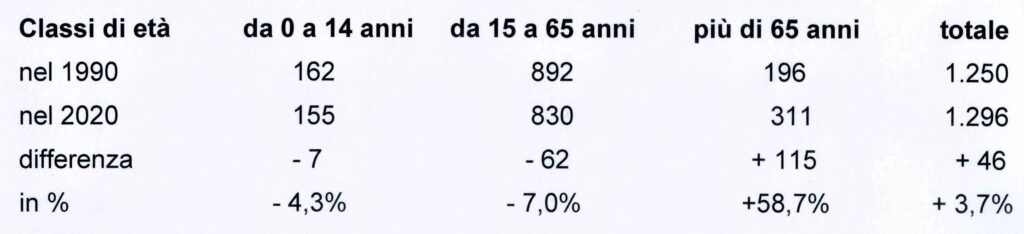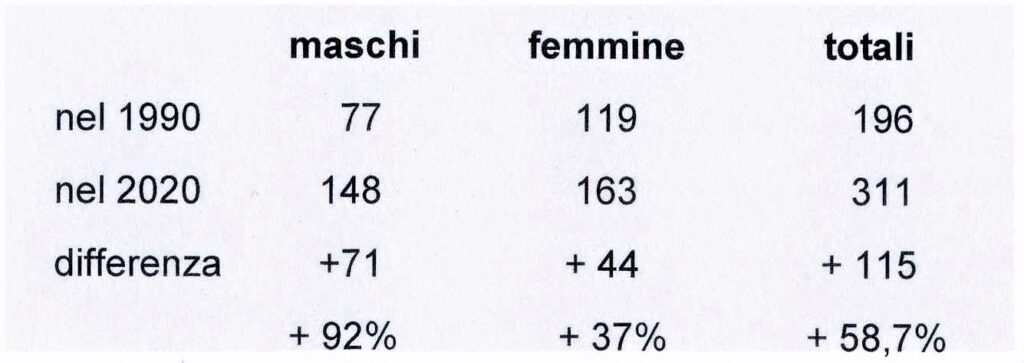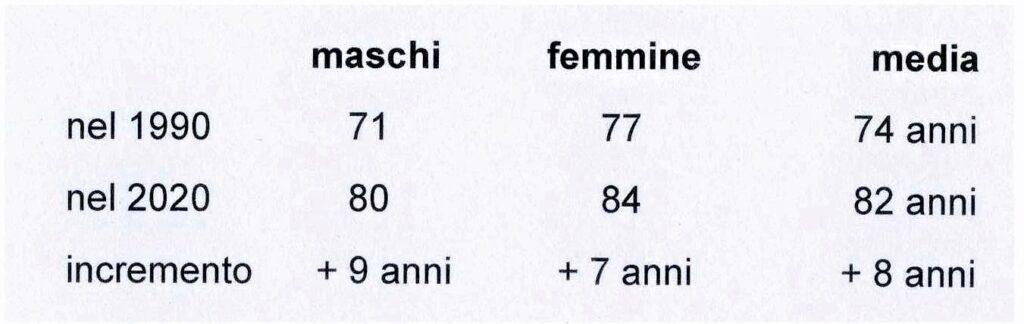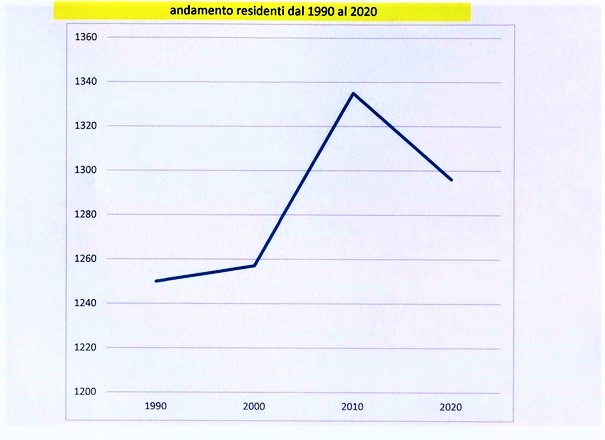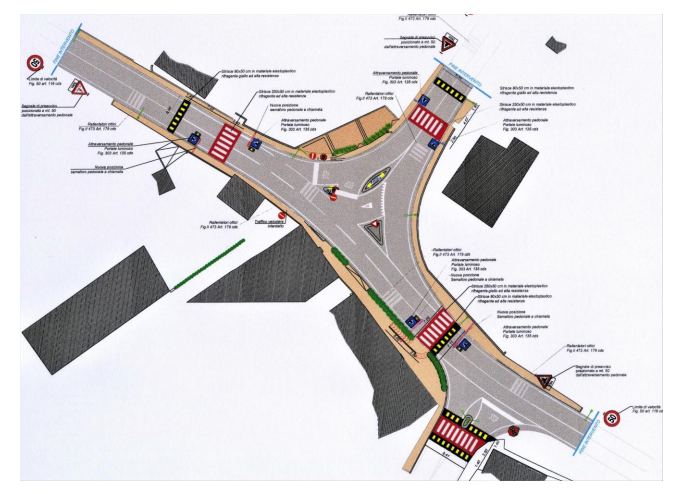SFIDE E OPPORTUNITA’
di Monica Testolin e Sofia Cappozzo
Nel mondo: che la pandemia abbia avuto un impatto sconvolgente nel mondo/mercato del lavoro è risaputo ma sappiamo quanto in termini di numeri?
Il tasso di disoccupazione è salito a livelli record, il numero degli inattivi (soggetti esclusi dalla forza lavoro poiché non occupati e nemmeno in cerca di un impiego) ha subito una brusca impennata che ha superato le stime dei disoccupati – individui, anche questi, non appartenenti alla categoria degli occupati tuttavia attivi nella ricerca di un lavoro o propensi ad avviare un’attività autonoma.
33 milioni di individui hanno perso il posto di lavoro, contro i 21 milioni del 2009 (anno in cui l’economia mondiale risentì pienamente degli effetti della crisi finanziaria originatasi negli Stati Uniti).

E in Italia?
945 mila i posti di lavoro persi in un anno a causa della crisi economica portata dal covid. A farne le spese, come era facile intuire, sono stati soprattutto i lavoratori a termine, -372 mila e gli autonomi, -355 mila, un dato al minimo storico. Sono aumentati gli inattivi, cioè quelle persone che non hanno un lavoro e non lo cercano, di ben 717 mila unità. Nonostante il blocco dei licenziamenti per molti settori, sono diminuiti anche i dipendenti stabili.
Secondo quanto dichiarato dall’INPS, le ore di cassa integrazione erogate lo scorso anno sono state oltre 4 miliardi). La perdita dei posti di lavoro ha coinvolto tutti, a prescindere dal sesso e dall’età, ma è stata più marcata per le donne e per gli under 35.
Nello specifico, il calo del tasso di occupazione femminile è stato quasi il doppio di quello maschile – molte donne durante la pandemia hanno dovuto lasciare il lavoro per occuparsi dei figli considerato che con asili e scuole chiuse conciliare vita lavorativa e familiare, senza un supporto, era molto difficile.
Relativamente ai settori maggiormente colpiti, l’ultimo anno è stato sicuramente difficile per tutti i comparti lavorativi del nostro Paese, ma ci sono delle aree che sono state colpite più di altre: il comparto alberghiero e della ristorazione, dei trasporti, della cultura, dello sport e dell’intrattenimento.
Un altro settore che ha risentito pesantemente degli effetti della pandemia è stato quello dei servizi domestici alle famiglie, con un impatto maggiore per gli stranieri e le donne.
L’industria dell’abbigliamento e del tessile ha subito gravi perdite: l’indice che ne calcola il fatturato medio a livello europeo è diminuito di 26 punti tra il 2019 e il 2020. Questa ampia differenza è dovuta sia ai molti mesi in cui i negozi del settore hanno dovuto lavorare a ritmo ridotto, sia ai cambiamenti nello stile di vita e nelle necessità che la pandemia ha introdotto. Fortunatamente l’arrivo, in tempi rapidi, del vaccino e la ripresa economica di questi ultimi mesi è un buon segnale; secondo gli ultimi dati ISTAT sono stati recuperati 523.000 posti di lavoro dei 945.000 persi nel 2020. Per consolidare la ripresa è fondamentale saper usare nel migliore dei modi l’opportunità fornita dall’Europa con il “Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. A rallentare la ripresa rimangono delle nubi all’orizzonte causate del forte aumento delle materie prime e del conseguente costo dell’energia.

LA RICERCA DEL LAVORO
Ma se da un lato il covid ha scosso l’intero sistema economico, portando, come visto, una profonda crisi, dall’altro ha dato l’opportunità di rivedere alcuni paradigmi che rischiavano di paralizzare il mondo del lavoro, accelerando il processo di digitalizzazione in ogni ambito e responsabilizzando maggiormente i dipendenti attraverso il lavoro da remoto.
Nel 2020 è cambiato non solo il mondo del lavoro, ma anche il modo di cercarlo: la fa da padrona la ricerca on line e quindi utilizzo del web.
Da uno studio sulle ricerche fatte on line dagli utenti in Italia, si è notato un aumento nel ricercare lavoro per alcune specifiche aziende, soprattutto supermercati e corrieri, probabilmente viste come professioni più sicure durante la pandemia e meno a rischio di eventuali licenziamenti o cassa integrazione.
L’item “lavorare con Amazon” è quello che ha registrato l’incremento più alto (+ 236%) con più di 11.300 ricerche ogni mese, e picchi di 22.000 a settembre e novembre 2020. “Bartolini lavora con noi”, invece, ha registrato un +71% con una media di 11.500 digitazioni ogni mese.
Crescita a +70% per l’item “MD lavora con noi”, che nel 2020 ha registrato una media di quasi 14.000 ricerche ogni mese, e picchi di 22.200 a settembre, ottobre e novembre 2020, mentre “Coop lavora con noi” ha segnato un +56% con una media di 157.00 digitazioni mensili.
Per quanto riguarda i siti per la ricerca di lavoro, Indeed.com è stato il portale più cliccato, quasi 14milioni e 900 mila volte ogni mese (+15% sul 2019), mentre Jobbydoo.it è stato quello con la crescita maggiore, con un incremento del 79% rispetto all’anno precedente e una media di 3 milioni di accessi mensili.
A cambiare, però, non è stato solo il modo di cercare lavoro, ma anche come si valutano i potenziali candidati e ciò che si ricerca nelle figure professionali da assumere.
In un contesto in continuo mutamento, a fare la differenza nella scelta delle migliori figure professionali da inserire nel proprio team sono le soft skills*.
Le soft skills ora incidono quasi il 40% nella scelta del candidato: tra le competenze più richieste la capacità di adattarsi ai cambiamenti, di lavorare sotto stress e per obiettivi, ma anche la flessibilità, intensa non solo come quella oraria, quanto di mansioni lavorative. Quest’ultima capacità si rende necessaria, come è stato nel caso della pandemia e del passaggio allo smart working, che ha portato molte persone a lavorare in modo diverso.
Inoltre, tra gli strumenti che pesano di più nel giudizio della valutazione del CV, a parità di competenze, c’è sicuramente la lettera di referenze firmata da ex datori di lavoro, ma anche da ex colleghi, per approfondire la storia professionale del candidato, la sua capacità di lavorare in team o le sue doti di leadership e di raggiungere gli obiettivi prefissati.
*soft skills : serie di competenze trasversali come la capacità di saper comunicare efficacemente, saper lavorare in gruppo, essere in grado di tener testa allo stress,.., ovvero capacità relazionali e comportamentali che caratterizzano la nostra persona e il modo in cui ci poniamo rispetto al contesto lavorativo.

NUOVE COMPETENZE E SOFT SKILLS PER ADATTARSI AI NUOVI CONTESTI
A causa del Covid, tante persone hanno perso il lavoro, tante attività hanno chiuso per diversi mesi, altre sono ancora in attesa di riaprire. In un contesto del genere cambiare lavoro è diventato ancora più complesso.
A parità di CV e di competenze tecniche, le soft skills vengono, oggi a maggior ragione, considerate una marcia in più: queste sono più importanti del numero di anni di esperienza o delle competenze tecniche. Questo perché chi padroneggia le soft skills è più capace e soprattutto più veloce, nell’adattarsi ai cambiamenti e alle novità, che nel contesto che stiamo vivendo sono all’ordine del giorno.
Formazione, competenze e soft skills rappresentano quindi la base per chi vuole affermarsi nel mercato del lavoro attuale e avere accesso ad un numero maggiore di opportunità per la propria carriera e per la propria soddisfazione personale e professionale.
SMART WORKING
L’emergenza ha portato tante realtà a ricorrere a modalità di lavoro mai provate prima, permettendo ai dipendenti di lavorare da casa.
Lo Smart Working è stato nell’ultimo anno al centro dell’attenzione mediatica, in quanto misura in grado di garantire la continuità di business e allo stesso tempo salvaguardare la salute pubblica.
A novembre 2020 l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha evidenziato che “durante la fase più acuta dell’emergenza, lo smart working, in Italia, ha coinvolto il 97 % delle grandi imprese, il 94% delle pubbliche amministrazioni italiane e il 58% delle PMI, per un totale di 6,58 milioni di lavoratori agili, circa un terzo dei lavoratori dipendenti italiani, oltre dieci volte più dei 570mila censiti nel 2019“. La fine del lockdown ha invece portato a nuovi cambiamenti, con le aziende e la pubblica amministrazione che hanno ricominciato ad aprire gli uffici, promuovendo un’integrazione tra lavoro in ufficio e lavoro da remoto: così, secondo i dati dell’Osservatorio, a settembre «il numero complessivo di smart worker è sceso a quota 5,06 milioni».
Per quanto possano esserci delle problematiche che successivamente verranno analizzate, non è possibile trascurare i benefici che la possibilità di lavorare da casa ha generato per aziende e dipendenti, offrendo innanzitutto la possibilità di portare avanti le proprie attività in un momento storico in cui senza le tecnologie a disposizione sarebbe stato impossibile. Secondo l’Osservatorio vi sarebbero altri fattori positivi: nel 71% delle grandi imprese italiane sarebbero migliorate le competenze digitali dei dipendenti; nel 65% di esse sarebbero stati sfatati dei pregiudizi sullo smart working; si sarebbe verificato, inoltre, un ripensamento dei processi aziendali nel 59% delle grandi imprese e nel 42% delle PA. Una ricerca condotta dal Centro di Ateneo – Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, basata sulla risposta di 446 individui a due questionari somministrati a marzo e a luglio 2020, si è focalizzata invece sulla risposta dei lavoratori. Stando a questi dati sembra che molti di essi percepiscano questa modalità di lavoro come positiva: più di un lavoratore su due sarebbe molto contento o del tutto contento di lavorare da casa. Tra i lavoratori soddisfatti di lavorare da casa il 79,2% presenta come principale vantaggio il risparmio di tempo e costi di viaggi; il 64,5% mette in risalto il senso di sicurezza rispetto alla possibilità di contagio; quasi il 60% afferma invece di riuscire a gestire meglio gli impegni della vita privata.

A livello aziendale, nei periodi non inclusi nel lockdown totale, il regime di utilizzo dello smart working si è attestato con regolarità su almeno due giorni a settimana, senza creare difficoltà nella continuità del business.
Inoltre, il ricorso a forme di smart working ha permesso di accelerare la trasformazione digitale dei processi organizzativi nelle imprese in cui erano già stati avviati significativi investimenti su nuove architetture informatiche e nuovi sistemi informativi (a supporto di attività di vendita, esercizio e manutenzione, virtualizzazione di macchinari e apparati di rete, e strumenti di lavoro collaborativo a distanza).
Tuttavia le difficoltà nell’adattarsi a questo nuovo approccio al lavoro, specialmente per chi si è ritrovato a doverlo fare per la prima volta, come già sottolineato in precedenza, ci sono. La pandemia ha d’altra parte accelerato in maniera improvvisa e forzata un processo di digitalizzazione che per molte aziende sarebbe probabilmente avvenuto successivamente. La necessità urgente di richiedere ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni da casa ha generato delle problematiche di diverso tipo.
Innanzitutto, alcuni problemi riguardano la mancanza di strumenti adatti a svolgere il proprio lavoro da casa: come riportano i dati dell’Osservatorio, il 69% delle grandi aziende ha dovuto aumentare la dotazione di computer portatili e di altri strumenti hardware; il 65% ha dovuto aumentare la dotazione di strumenti per poter accedere da remoto agli applicativi aziendali in tutta sicurezza; il 45% ha dovuto invece aumentare quella di strumenti per la collaborazione e la comunicazione.
un altro aspetto importante riguarda work-life balance e repentino bisogno di imparare a conciliare lavoro e faccende domestiche (principalmente per i genitori con figli minorenni, la cui situazione è stata resa ancor più difficile dalla chiusura di scuole e asili nido). La ricerca condotta dal Centro di Ateneo – Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha fatto luce anche su questo tema e sull’impatto di questi cambiamenti sul benessere dei dipendenti. Tra i principali svantaggi riportati dagli intervistati è possibile menzionare la mancanza di momenti di pausa nella giornata lavorativa (nel 53,4% dei casi) e lo stress correlato all’uso della tecnologia (per il 51% degli intervistati). Infine, lo studio ha rivelato che un lavoratore su due che lavora da casa percepisce di lavorare più del solito.

Possibili scenari
L’aumento del lavoro da remoto e dello smart working durante la pandemia ha cambiato la percezione che molte aziende avevano di queste modalità di lavoro e, secondo quanto riportato dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, una volta finita l’emergenza potrebbero esserci circa 5,35 milioni di persone a lavorare almeno in parte da remoto. Nonostante le tante sfide e gli ostacoli, molte voci puntano nella stessa direzione: come ha affermato Gianluigi Cogo, -Project Manager Open Innovation Regione Veneto da quando la pandemia è iniziata sono stati tanti gli italiani che si sono dovuti adeguare a «una modalità ibrida di lavoro che probabilmente diventerà la nuova normalità, non ci sarà più un ritorno a tutti in ufficio e pochi in modalità agile».
Una previsione simile emerge anche dalla ricerca di Randstad “Lavoro e studio ‘intelligenti’: la trasformazione possibile“. Come si legge nel comunicato stampa di lancio della ricerca, Daniele Fano, coordinatore del comitato scientifico di Randstad Research, ha affermato che «il futuro dello studio e del lavoro sarà “integrato“, un combinato di attività svolte a distanza con supporti digitali e con piena flessibilità di orario e di altre in presenza che richiedono condivisione e interazione tra persone».
È importante, dunque, che le aziende e le PA si impegnino per riuscire a cogliere al massimo il potenziale di questo approccio ibrido al lavoro, diviso tra casa (o un altro luogo) e la sede di lavoro, garantendo ai dipendenti le condizioni ottimali per poter essere produttivi e per trovare il giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale.
Fonti: Istat e ADNKronos